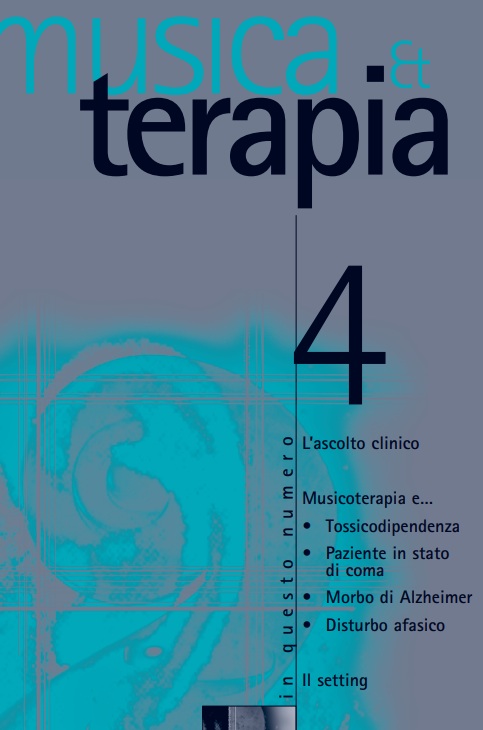Musicoterapia e Setting Atipico: 'Al letto del Paziente' ⊵
In musicoterapia clinica, l'ambiente fisico non è mai un dettaglio neutro.
Al contrario, il setting assume la funzione di fattore terapeutico prevalente, specialmente quando operiamo con pazienti la cui patologia compromette gravemente le funzioni psico-corporee

Lavorare al letto del paziente in contesti di degenza (ospedali, hospice, residenze, domicilio) ci obbliga a rinunciare alla stanza ideale, ma non al rigore metodologico.
La nostra azione deve concentrarsi sulla ricostruzione attiva del contenitore terapeutico in uno spazio che è già carico di significati e vissuti.
Per affrontare questa sfida, il punto di partenza imprescindibile è la rigorosa definizione strutturale fornita da Massimo Borghesi e Andrea Ricciotti.
Essi definiscono il setting come la sovrapposizione armonica di tre cornici, la cui funzionalità è preposta non solo al processo, ma alla integrazione spaziale dell'individuo e alla fondamentale distinzione tra sé e non sé.
1. La Cornice Spaziale: Il Luogo della Differenziazione
La cornice spaziale è forse l'elemento più messo in crisi nel setting atipico. Non si tratta solamente dello spazio fisico, ma della sintesi di spazio fisico, spazio psicologico e spazio acustico.
Questo contenitore tridimensionale è vitale per l'integrazione dell'identità del paziente.
Borghesi e Ricciotti evidenziano che la mancata individuazione di un setting chiaro e ben delimitato è estremamente rischiosa: essa favorisce la frammentazione del paziente e la possibilità di fughe, intese come proiezioni motorie nel mondo esterno o spostamenti inefficaci da un canale espressivo all'altro.
Considerato che spesso non è disponibile un laboratorio esclusivo, l'attenzione del clinico si sposta sui dispositivi per la caratterizzazione e la delimitazione dello spazio.
Gli strumenti musicali, in questo senso, devono essere introdotti con intenzionalità clinica e non rimanere come mero arredamento.
L'obiettivo ultimo è che, lavorando sulla riconoscibilità del setting musicoterapico, una riconoscibilità che si ottiene anche attraverso la stabilità sensoriale e acustica, si permetta al mondo percettivo del paziente di assumere una maggior definizione.
In questo modo, lo spazio ben delimitato si trasforma, per il paziente, in uno spazio transizionale, un ponte che facilita la comunicazione non verbale e l'esternazione di simboli.

2. La Cornice Temporale: L'Ancoraggio della Regolarità
La cornice temporale abbraccia la durata della singola seduta e la cadenza dell'intero trattamento.
Per pazienti che vivono in un tempo spesso indefinito (come quello della degenza), una scansione irregolare o imprevedibile del tempo della seduta può generare destabilizzazione e indurre fughe temporali.
È pertanto fondamentale per il musicoterapeuta mantenere uno stile di regolarità e gestire con estrema consapevolezza e flessibilità qualsiasi variazione della durata.
La stabilità del tempo cronometrico (orari e frequenza) diventa una costante, un "processo" che offre al paziente una bussola emotiva e un elemento di contenimento.
Questo rigore è necessario per proteggere il setting dalle pressioni esterne (familiari, istituzionali) e consentire al percorso terapeutico di svolgersi secondo la propria dinamica.
La regolarità della scansione temporale è ciò che permette di segnare una "storia" clinica nel tempo, elemento essenziale per l'elaborazione.
3. La Cornice Comportamentale: La Creazione di Opportunità Simboliche
La cornice comportamentale definisce le regole implicite ed esplicite della relazione ed è indispensabile per la perimetrazione del setting e per garantire che il processo si svolga in sicurezza e con finalità terapeutiche.
Il suo fulcro risiede nell'applicazione di una "regola fondamentale" tipica della musicoterapia: il paziente accetta di essere completamente spontaneo con il musicoterapista attraverso la tecnica dell'improvvisazione musicale.
I suoni, in questo contesto protetto, diventano l'equivalente delle libere associazioni, dando voce alle potenzialità elaborative del paziente.
Altro aspetto cruciale è la possibilità di fornire al paziente oggetti transizionali.
Attraverso la delimitazione stabile delle cornici, si riducono i margini per una proiezione motoria o materiale nel mondo esterno (le vie di fuga).
Di conseguenza, il mondo sensoriale\percettivo del paziente riceve stimolo e nutrimento a diventare spazio transizionale, in cui il musicoterapeuta può fornire oggetti sonoro-musicali con funzione sia consolatoria che, in senso più ampio, di occasioni di logos.
Questo logos, inteso come comunicazione non verbale (musicale, corporea, gestuale), tende a favorire la costruzione e l'esteriorizzazione in forma comunicativa di simboli.
È in questo modo che si dà voce, o almeno suono, alle potenzialità elaborative, facendole emergere da quel "magma pre-elaborativo" che costituisce il substrato psico-corporeo nelle situazioni di deficit

AREA RISORSE GRATUTITE
Il corso (gratuito) Introduttivo alla Musicoterapia
offerto da MusicoterapiaViva.it
➤L'Elemento Distintivo: Il Contesto Non Verbale (Benenzon)
L'impalcatura rigorosa delle cornici definita da Borghesi e Ricciotti trova la sua specificità clinica nella natura profonda della nostra disciplina.
Come teorizzato dal pioniere Rolando Benenzon, l'elemento che distingue il setting musicoterapico da tutti gli altri approcci terapeutici è il contesto non verbale.
Questa prospettiva non implica l'esclusione totale della parola, ma ne definisce un ruolo specifico: la parola è presente alla pari di altri codici, assumendo un maggior rilievo nel significante e nel suono, piuttosto che nel significato denotativo vero e proprio. Il fulcro è che la comunicazione si basa su una matrice sensoriale molto più ampia.
➤Il Mondo di Codici in Movimento
Il contesto non verbale, secondo Benenzon, è dato dall'interazione dinamica di infiniti elementi o messaggi.
Questo complesso sistema include codici quali quello sonoro, musicale, gestuale, corporeo, del movimento, prossimale, della mimica, dell'odore, del colore, dello spazio, vibrazionale, gravitazionale, della temperatura e del gusto.
Tutta questa ricchezza sensoriale è chiamata a influenzare e stimolare il sistema percettivo globale dell'essere umano, consentendogli di riconoscere l'ambiente che lo circonda e l'essere umano con cui è portato a mettersi in comunicazione.
Questa visione ci impone una cura specifica per l'ambiente, specialmente in un setting atipico:
• Acustica e Contenimento Sonoro:
Se la regola ideale impone che il setting sia il più isolato possibile da interferenze sonore esterne, nella camera di degenza ciò è un'utopia.
La clinica, in questi casi, ci insegna che, se i suoni esterni pervengono (come il brusio di un reparto o il rumore dei macchinari), essi non devono essere ignorati, ma riconosciuti e inglobati nel contesto della seduta.
In questo modo, il musicoterapeuta non li subisce, ma li trasforma in un dato clinico da contenere nella propria risposta sonora. Questo accorgimento permette di lavorare in una condizione di relativa libertà interna.
• Spazio e Corpo come Codici:
La consapevolezza che il setting influenzi il comportamento è cruciale. Benenzon ha notato come modificando il setting avvengano cambiamenti nella condotta dei pazienti.
Pertanto, nel setting ristretto (al letto), la gestione delle dimensioni è essenziale. La sala deve avere dimensioni "giuste".
Lo spazio troppo grande provoca dispersione e favorisce l'isolamento; lo spazio troppo piccolo ovatta l'ascolto, distorcendone le frequenze.
In entrambi i casi, diminuiscono le possibilità che si crei lo spazio vincolare (lo spazio creativo), che si forma solo in funzione delle energie emesse da entrambi.
Il pavimento in legno, ideale per la trasmissione di vibrazioni, viene simulato in questo contesto attraverso l'uso di strumenti o strategie (es. casse bluetooth) a 'contatto' che massimizzano la componente tattile e vibratoria.

➤La Transtemporalità come Processo Terapeutico: L'Incontro dei Tempi
L'integrazione di questi codici non verbali si manifesta pienamente nella dimensione del tempo.
Non esiste possibilità di presenza sonora senza il trascorrere del tempo; analogamente, non esiste possibilità di presenza terapeutica senza un processo che si svolga in un tempo determinato e che segni una storia.
In un setting di musicoterapia si distinguono tre tempi caratteristici che si compenetrano in una dinamica complessa:
- ➤ Il Tempo Cronologico: È il tempo oggettivo e misurabile, il tempo cronometrico. Questo tempo stabilisce la durata della singola seduta e la frequenza degli incontri. Nel contesto clinico, pur dovendo mantenere la regolarità come elemento di contenimento (ricordando i principi di Borghesi e Ricciotti), è il tempo che può essere più soggetto a variazioni a causa di vincoli esterni o dalla tolleranza fisica del paziente grave.\
- ➤ Il Tempo Biologico: Questo è il tempo che risale al nostro periodo fetale e che, nel corso della convivenza con la civiltà, tendiamo a perdere. È il tempo primitivo, ritmico, che risuona con il battito cardiaco materno e il flusso amniotico. È facilmente riconoscibile in pazienti con patologie regressive o stati di isolamento profondo. Una delle funzioni fondamentali del musicoterapista è proprio riscoprire questo tempo biologico perduto e riadattarlo alle necessità espressive e relazionali del paziente.\
- ➤ Il Tempo Terapeutico: Caratterizza il cuore della relazione clinica. Non è la semplice somma dei due precedenti, ma è dato dall'adeguamento reciproco dei tempi biologici di musicoterapeuta e paziente. È attraverso questa sintonia ritmica e sonora che si crea un dialogo profondo, pre-verbale e non verbale. È terapeutico perché permette al paziente di tornare a riconoscere il proprio tempo biologico, che è stato dimenticato, trasformato, atrofizzato o distorto dalla 'condizione'.\

Il Tempo Terapeutico integra gli altri due, e tutti e tre, simultaneamente, determinano la dinamica del processo primario e secondario che Fiorini chiama "transtemporalità".
La transtemporalità è un tempo che ha origine solo all'interno dello spazio creativo o vincolare precedentemente delimitato.
Essa rappresenta la capacità del processo di andare oltre i limiti del tempo misurabile, consentendo al paziente di esplorare e integrare il proprio passato primitivo (biologico) all'interno della sicurezza del presente (cronologico e terapeutico).
In un setting al letto, la stabilità cronologica della seduta funge da ancoraggio indispensabile per permettere al paziente di affrontare e riorganizzare il proprio Tempo Biologico senza dispersione
Il Contenitore Interiore: L'Holding Attivo di Winnicott
Il ponte concettuale che ci permette di applicare la rigorosa struttura delle cornici (Borghesi/Ricciotti) e l'interazione dinamica dei codici non verbali e temporali (Benenzon) in un contesto clinico di estrema vulnerabilità è offerto dalla visione di Donald Winnicott.
Per il musicoterapeuta che opera al letto del paziente, il setting non è uno sfondo, ma una "somma di tutti i dettagli della tecnica", elevata a funzione di contenitore psichico.
Winnicott è stato il primo a concettualizzare il setting come l'insieme degli elementi concreti e simbolici (spazio, tempo, regole, ruolo del terapeuta) che formano il "contenitore" sicuro e stabile della relazione terapeutica.
➤Setting come Holding e Incubatrice: L'Essenza del Contenimento
Il setting, nella prospettiva di Donald Winnicott, si eleva da mero sfondo ambientale a "cornice attiva e necessaria" del processo terapeutico.
Non è un elemento statico, bensì il dispositivo essenziale per la sopravvivenza psichica del paziente.
1-Sicurezza e Fiducia: La Stabilità del "Non-Processo"
Il setting è primariamente concepito come il dispositivo che crea un ambiente di sicurezza emotiva in cui la regressione clinica, tipica dei pazienti gravi, può avvenire senza condurre alla frammentazione.
La sua stabilità è incarnata dalle costanti del processo: orari, frequenza e il ruolo del terapeuta.
Questa costanza, definita dal post-winnicottiano José Bleger come il "non-processo", rappresenta l'elemento immutabile, lo sfondo costante, entro cui il vero processo terapeutico (l'instabilità emotiva, il transfert e il controtransfert) può svolgersi.
La rigorosa aderenza a queste costanti, anche in un setting atipico, infonde la fiducia necessaria, permettendo al paziente di deporre le sue difese e di avviare l'elaborazione dell'esperienza.
2-La Funzione di Contenimento (Holding): Il Sostegno Emotivo
Il setting fornisce il contenimento psichico (o Holding) essenziale per sostenere le difficoltà del paziente.
Questa funzione riproduce l'equivalente clinico della cura materna sufficientemente buona (good enough mother) nel rapporto madre-bambino.
Come la madre offre un holding (sostegno fisico ed emotivo) che protegge il lattante dalla disintegrazione e gli permette di esistere, così il setting clinico deve essere sufficientemente buono da sostenere l'angoscia del paziente.
Nel contesto della musicoterapia al letto, dove i confini fisici sono labili, il terapeuta incarna questa funzione: la sua presenza costante e sintonica diventa il contenitore simbolico che permette al paziente di sentirsi protetto e di sviluppare fiducia, facilitando l'emergere del processo di elaborazione.
3-Strutturazione dell'Io e Spazio Transizionale: L'Incubatrice della Creatività
È all'interno di questo ambiente protetto e contenitivo che il paziente può avviare un processo di riorganizzazione e potenziamento delle proprie risorse residue.
La stabilità del setting funge da vera e propria incubatrice, offrendo le condizioni di base per lo sviluppo dell'organizzazione psichica ed espressiva.
In questo processo, il corpo del paziente, la sua gestualità e la sua re(L)azione al suono, giocano un ruolo fondamentale.
La fiducia generata dal contenimento consente l'uso dello spazio transizionale, quell'area intermedia, neutra e creativa, tra la realtà interna e quella esterna.
La musica e il suono, con la loro natura a cavallo tra realtà interna ed esterna, si situano perfettamente in quest'area, trasformando il setting al letto nel luogo dove si collocano la creatività e il l'esperienza sonora, elementi indispensabili per l'integrazione espressiva e il ritrovamento di un senso di coesione interna.

➤L'Evoluzione Dinamica del Contenitore
Il concetto di setting si è evoluto da una visione inizialmente più rigida a una più fluida e dinamica, adattabile ai diversi orientamenti.
Questa dinamicità è cruciale quando si lavora al letto del paziente, dove la cornice fisica è intrinsecamente fragile.
In questi contesti, la funzione di holding si sposta interamente sulla costanza relazionale e sull'atteggiamento del musicoterapeuta.
La stabilità del setting, come somma dei dettagli tecnici (Borghesi/Ricciotti), della comunicazione non verbale (Benenzon) e della funzione di contenimento (Winnicott), non è dunque uno sfondo.
Essa è la condizione sine qua non affinché il paziente possa abbandonarsi alla spontaneità e libertà richiesta dalla relazione e avviare quel dialogo sonoro profondo che, in assenza di un contenitore sicuro, si tradurrebbe in angoscia e frammentazione.

➤La Sintesi Clinica: La Musicoterapia al Letto come Holding Sonoro
Sulla base dei tre pilastri teorici fondamentali – la struttura delle cornici di Borghesi/Ricciotti, l'interazione dei codici non verbali di Benenzon e la funzione di holding e contenimento di Winnicott – possiamo ora sintetizzare in modo coerente ed eloquente l'azione clinica nel setting non convenzionale al letto del paziente.
La sfida è trasformare un luogo di degenza in uno spazio vincolare di elaborazione.
🔸 Il Terapista come Cornice Attiva
Anche se il letto si trova in una stanza, l'ambiente che per definizione non è isolato e non risponde ai requisiti ideali, il musicoterapeuta non è semplicemente un ospite o un tecnico.
Egli incarna la funzione del setting.
Diventa l'agente attivo che, attraverso l'intenzionalità clinica e la costanza relazionale, si impegna a rimodellare l'ambiente, trasformandolo in uno spazio transizionale protetto.
Questa azione di ricostruzione ambientale è una forma di Holding Attivo che risponde direttamente alla necessità winnicottiana: la sua presenza stabile e sintonica funge da custode e mediatore delle cornici.
Il musicoterapeuta, in sintesi, si fa carico della funzione di contenimento che l'ambiente fisico non può principalmente offrire.
➤Delimitazione Spazio-Strumentale e Vibrazionale
La cornice spaziale al letto del paziente non può essere delimitata da mura fonoassorbenti, ma è circoscritta dall'introduzione intenzionale degli strumenti, che diventano dispositivi di focalizzazione e contenimento del campo.
➤Valore Vibrazionale e Tattile:
La scelta di strumenti che massimizzano la componente vibrazionale (come ciotole armoniche, ocean drum o percussioni manuali ecc.) è da tenere in considerazione.
Sfruttando il codice non verbale del tatto e della vibrazione (Benenzon), questi suoni-vibrazioni a contatto superano la frammentazione sensoriale tipica della patologia grave\complessa.
Le risonanze agiscono come oggetti transizionali sonori (Borghesi/Ricciotti), fornendo un sostegno sensoriale concreto che supplisce alla mancanza di confini fisici stabili e rassicuranti. Questo ancoraggio corporeo è fondamentale per la distinzione tra sé e non sé.
➤Valore Simbolico e Proiettivo:
Oltre al fattore vibrazionale, gli strumenti sono selezionati per il loro potenziale di simbolizzazione e per la loro capacità di facilitare la proiezione del mondo interno con un minimo dispendio energetico da parte del paziente.
Strumenti dalla timbrica ricca e definita (es. arpe da tavolo, metallofoni) permettono al paziente di esprimere un mondo interno complesso e sfumato. Questa selezione oculata contribuisce in modo decisivo a rendere lo spazio acustico riconoscibile e dotato di un "vocabolario" sonoro che stimola il paziente a costruire ed esteriorizzare in forma comunicativa i suoi simboli (il logos).
L'oggetto sonoro, in questo senso, funge da ponte verso l'espressione di potenzialità elaborative.
➤Valore Ergonomico e di Accessibilità:
Questo valore è vitale nel setting al letto. Riguarda l'uso di strumenti costruiti ad hoc o riadattati in base alle specifiche limitazioni motorie, neurologiche e sensoriali del paziente.
L'obiettivo è garantire che l'espressione musicale sia accessibile con il minimo sforzo e il massimo controllo possibile.
Ad esempio, l'utilizzo di strumenti montati su supporti ergonomici o l'uso di sensori, tastiere a sfioramento, permettono al paziente di partecipare attivamente, superando le barriere fisiche e ripristinando un senso di agency e autonomia espressiva.
➤Ancoraggio Transtemporale
In un contesto di degenza dove il tempo interiore è spesso sospeso o indefinito, la regolarità della seduta (Tempo Cronologico) funge da costante (il "non-processo" di Winnicott/Bleger) essenziale per la sopravvivenza psichica.
Questa coerenza temporale è l'àncora necessaria che permette al paziente di sentirsi al sicuro e di affrontare e riorganizzare il proprio Tempo Biologico primitivo.
Attraverso la sintonizzazione ritmica e l'adeguamento reciproco dei tempi (il Tempo Terapeutico, Benenzon), il musicoterapeuta stabilisce una sintonia profonda che è il cuore dell'holding sonoro.
Questo facilita la dinamica di transtemporalità, consentendo al paziente di esplorare il proprio passato senza la minaccia della dispersione temporale (le fughe temporali descritte da Borghesi e Ricciotti).
➤Contenimento Comportamentale
La stabilità della cornice comportamentale, incentrata sull'accettazione della spontaneità musicale come regola fondamentale, incarna il contenimento winnicottiano.
Essa non è una mera prescrizione tecnica, ma un invito fiduciario che permette al paziente di sentire i propri impulsi emotivi e le proprie angosce contenuti all'interno della forma simbolica e protetta del suono e dell'improvvisazione.
La stabilità della cornice comportamentale (incentrata sulla spontaneità musicale) incarna il contenimento offerto dal terapeuta.
Riuscendo a incanalare le tensioni e i sentimenti intensi in vie espressive simboliche (il logos sonoro), si riduce la necessità per il paziente di manifestare il proprio disagio attraverso comportamenti di fuga o agitazione fisica.
In questo modo, l'energia del paziente viene trasformata in energia utile all'elaborazione e alla comunicazione.
La cornice, mantenuta ferma dal terapeuta, protegge il processo e garantisce che lo spazio creato rimanga un contesto relazionale solido e capace di favorire l'espressione.
➤La Funzione Etica e Progettuale del Setting
Operare in questo setting non convenzionale è l'espressione più alta della nostra competenza, poiché esige la trasformazione continua di uno spazio di degenza in uno spazio vincolare, fornendo al paziente gli elementi sonoro-musicali per ritrovare l'integrazione espressiva e raggiungere un significativo benessere.
➤ È cruciale sottolineare, in conclusione, che l'analisi di queste cornici e l'integrazione di questi modelli teorici non costituiscono una mera indicazione operativa.
I setting clinici in musicoterapia, specialmente in contesti atipici e di vulnerabilità, vanno sempre costruiti secondo specifici criteri osservativi e valutativi.
Tali setting devono poi essere ridefiniti e condivisi in equipe multidisciplinari, un passaggio etico e metodologico imprescindibile. Infine, devono essere inseriti in un quadro progettuale che ne validi l'efficacia, la durata e gli obiettivi terapeutici nel tempo.
link Articolo presente sulla Rivista Musicoeterapia (pag 42 Il setting in Musicoterapia Massimo Borghesi, Andrea Ricciotti)
https://musicaterapia.s3-external-3.amazonaws.com/04-Musica-e-terapia.pdf
Questo Patrimonio è costituito dai Quaderni Di Musicoterapia A.P.I.M
L'APIM – Associazione Professionale Italiana Musicoterapeuti mette a disposizione, per la consultazione e il download in formato PDF, i numeri di Musica et Terapia,

Simone Rizzardi
Founder Musicoterapiaviva.it
✪ Musicoterapeuta, Operatore e Consulente nel Benessere del suono.
Esperto di applicazioni della musica in contesti Clinici e di Crescita personale. ✪ Musicista
e appassionato della Valorizzazione dei Talenti delle persone - Scopri chi è Simone